Le Idee
“Oltre La Terapia Intensiva Aperta”
di Sergio Livigni
Direttore Terapia intensiva dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino
 Cercherò di spiegare perché ritengo che l’apertura di una Terapia Intensiva non significhi soltanto “la razionale riduzione o abolizione di tutte le limitazioni non motivatamente necessarie poste a livello temporale , fisico, relazionale” (Giannini A. Open Intensive care units:the case in favour. Minerva Anestesiol 2007 73: 299- 305), o meglio, perché ritengo che questa riduzione o abolizione sia necessaria, ma non sufficiente.
Cercherò di spiegare perché ritengo che l’apertura di una Terapia Intensiva non significhi soltanto “la razionale riduzione o abolizione di tutte le limitazioni non motivatamente necessarie poste a livello temporale , fisico, relazionale” (Giannini A. Open Intensive care units:the case in favour. Minerva Anestesiol 2007 73: 299- 305), o meglio, perché ritengo che questa riduzione o abolizione sia necessaria, ma non sufficiente.
Il mio ragionamento parte dal principio morale utilitarista per cui ogni azione deve avere il fine di ottenere il massimo di utilità per tutti o per il maggior numero di individui interessati e dal rifiuto del paternalismo medico, cioè dell’atteggiamento secondo cui il medico conosce il bene del proprio paziente e può scegliere al suo posto proprio come un padre di famiglia conosce il bene dei suoi figli e sceglie per loro.
Nella pratica clinica non distinguo il sentire del medico/operatore sanitario da quello del paziente o del familiare, ma considero il medico/operatore sanitario anche paziente e familiare.
Spero di non essere troppo contorto nel ragionamento: ciò che può modificare il mio modo di agire (l’agire medico in questo caso) è la conoscenza delle conseguenze generate dall’azione che mi accingo a compiere o ad evitare, valutando le diverse posizioni dei soggetti interessati; nel caso della Terapia Intensiva cerco di eliminare tutte le limitazioni individuate da Giannini perché so che l’apertura della Terapia Intensiva segue un principio morale corretto.
Quali sono gli individui interessati? I pazienti, i familiari, gli operatori sanitari. Qualcuno ha un diritto maggiore, c’è un conflitto di diritti o di doveri? Il rispetto del diritto non risponde al principio morale utilitarista?
Assolutamente no! Continuare a mantenere chiuse le Terapie Intensive significa negare un diritto: il diritto alla giusta comunicazione, alla giusta relazione, il diritto alla presenza degli affetti più cari, il diritto di scelta, diritti di ognuno di noi.
Non si può continuare ad ignorare le maggiori raccomandazioni della letteratura scientifica per la buona pratica clinica: a tutti sono noti i concetti di decisioni condivise, attenzione comunicativa, consenso informato, l’importanza del supporto spirituale, dell’educazione del personale, quanto la presenza dei familiari durante manovre di rianimazione, l’assistenza, prima, durante e dopo un decesso. Dobbiamo accettare tutto questo e riconoscerne la giusta dignità per la cura del paziente.
Stabilita la necessità di quanto sopra siamo comunque in difetto perché ci limitiamo soltanto ad un aspetto del diritto.
Il diritto del paziente è molto più ampio: il medico non può compiere qualsiasi atto senza un consenso né evitare di dare informazioni; il medico deve riconoscere la sovranità del paziente sul proprio corpo e sulla propria vita.
Come sostiene Maurizio Mori “…E’ l’interessato che deve scegliere ciò che intende sia fatto sulla propria persona. In questo senso, il consenso informato determina due conseguenze importanti:
a. Il passaggio di titolarità decisionale, che prima spettava al medico mentre ora passa all’interessato;
b. Il riconoscimento che l’interessato ha sovranità sul proprio corpo e sulla vita ad esso connessa, punto che giustifica il passaggio di titolarità decisionale….”
A questo punto il modello terapeutico si modifica completamente; se comprendiamo ed accettiamo questo cambiamento possiamo dire di avere abbattuto tutte le barriere e scoperto o meglio riscoperto il significato della cura.
Ecco perché ritengo che si debba andare oltre… La cura non può terminare al momento della dimissione, ma deve continuare nel tempo, oltre le diagnosi e le terapie, in una continua ricerca della Persona più che della patologia.
Fonti:
Ospedaleaperto.com
 Il senso comune ha a che fare con la nostra sensorialità e con la possibilità di concordare sulla nostra esperienza sensoriale. Il senso comune e la sua costruzione presuppongono quindi alcune caratteristiche individuali e la presenza di una comunità di individui. Le carat-teristiche individuali sono la possibilità di esperire sensorialmente e di sentire. Ho utilizzato questo ultimo termine per riferirmi al campo emozionale dove, per esempio, non è possibile vedere la gioia ma provarla così come la paura, la tristezza e così via.
Il senso comune ha a che fare con la nostra sensorialità e con la possibilità di concordare sulla nostra esperienza sensoriale. Il senso comune e la sua costruzione presuppongono quindi alcune caratteristiche individuali e la presenza di una comunità di individui. Le carat-teristiche individuali sono la possibilità di esperire sensorialmente e di sentire. Ho utilizzato questo ultimo termine per riferirmi al campo emozionale dove, per esempio, non è possibile vedere la gioia ma provarla così come la paura, la tristezza e così via.?>/images/rss.jpg) Rss
Rss ?>/images/header_blog.jpg)
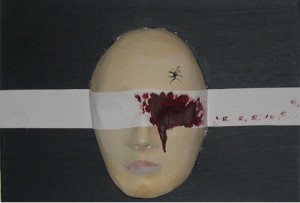



?>/images/facebook.png)